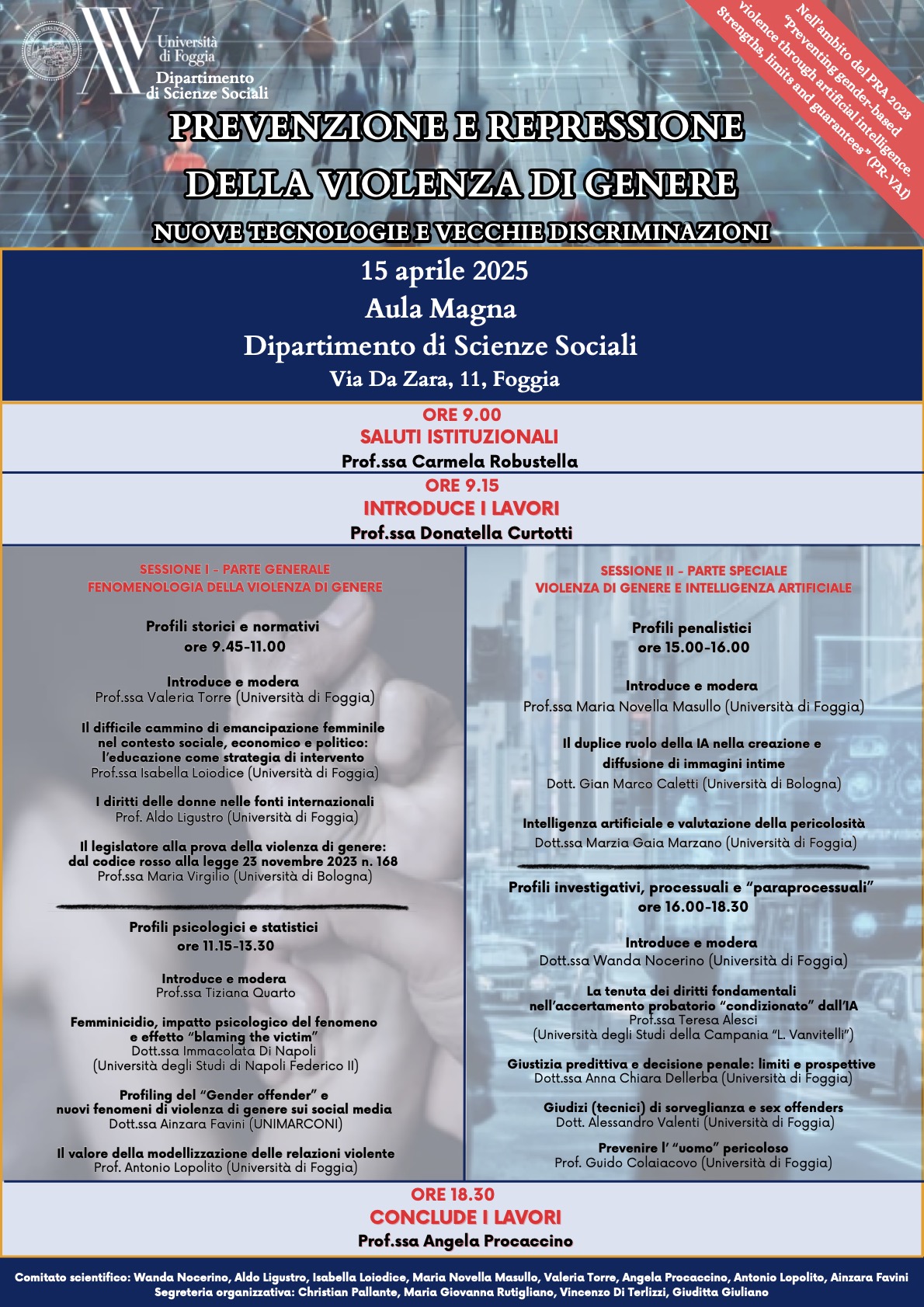Cass., sez. IV, 19 settembre 2024 (dep. 21 novembre 2024), n. 42614, Dovere, Presidente, Cirese, Estensore
Il caso
Il Tribunale di Sassari ha assolto l’imputato, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt. 40 comma 2, 438 comma 1 e 452 comma 1, n. 2, c.p. poichè ha ritenuto integrabile la fattispecie di epidemia soltanto a seguito della diffusione “attiva” di germi patogeni, escludendo così la rilevanza di condotte omissive (non contemplate dalla norma). Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza degli artt. 40 comma 2 e 438 c.p. e censurando la sentenza laddove ha ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 438 c.p. a condotte omissive.
La questione controversa
Il dubbio ermeneutico concerne la configurabilità in forma omissiva delle condotte tipiche di cui agli artt. 438 e 452 c.p., negata finora da due pronunce della Suprema Corte.
Il riferimento è, in primis, a Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, in C.E.D. Cass., n. 272261, secondo cui l’art. 438 c.p. «evoca […] una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con l’art. 40 comma 2 c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera». Tale decisione, quindi, non considera aderente al dettato normativo l’indirizzo dottrinario che inquadra le fattispecie di cui agli artt. 438 c.p. e 452 comma 2 c.p. nei c.d. «reati a mezzo vincolato» (si rimanda, senza pretese d’esaustività, a Corbetta, Delitti contro l’incolumità pubblica. Tomo II: I delitti di comune pericolo mediante frode, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da G. Marinucci ed E. Dolcini, Padova, 2014, p. 16; Piras, Sulla configurabilità dell’epidemia colposa omissiva, in www,sistemapenale.it, 8.7.2020).
Nella medesima prospettiva, si colloca Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 20416, in Riv. it. med leg., 2021, p. 1129, che ha rilevato come «in tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l’art. 438 c.p., con la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40 c.p., comma 2, riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera».
Dunque, nella giurisprudenza di legittimità non vi sono pronunce che accolgono espressamente un diverso indirizzo ermeneutico.
Tuttavia, Sez. I, 30 ottobre 2019, n. 48014, in C.E.D. Cass., n. 277791, pur non affrontando direttamente il tema della configurabilità in forma omissiva del reato di cui all’art. 438 c.p., contiene un obiter dictum secondo il quale «[…] la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede […] che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione; occorre, però, al contempo […] che sia una diffusione capace di causare un’epidemia».
In questo contesto, l’ordinanza di rimessione sostiene che la tesi accolta da Cass., sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133, cit. deve essere superata in favore di un’interpretazione più ampia, che ammette la realizzazione del reato in forma omissiva. Ciò sulla scorta del dato letterale, che non sembra precludere una simile ricostruzione, e di quanto recentemente ribadito dalle Sezioni Unite civili, secondo cui «l’attività interpretativa giudiziale è segnata, anzitutto, dal limite di tolleranza ed elasticità dell’enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell’inveramento della norma nella concretezza dell’ordinamento a opera della giurisprudenza stessa» (Cass. civ., Sez. un., 6 dicembre 2021, n. 38596, con nota di Nicolai, Sul rapporto tra sezioni civili e penali di un medesimo ufficio, in Riv. Dir. Proc., 3, 2022, p. 1101).
Secondo l’ordinanza di rimessione sarebbe quindi possibile ricomprendere nella nozione di “diffusione” le condotte omissive dato che – alla luce del sopracitato indirizzo dottrinario – il termine può ricomprendere forme non necessariamente implicanti un agire positivo e perciò si può diffondere anche “lasciando che si diffonda” (sull’assenza di preclusioni sul punto, Pelissero, Covid-19 e diritto penale pandemico. Delitti contro la fede pubblica, epidemia e delitti contro la persona alla prova dell’emergenza sanitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2020, p. 525). Una simile interpretazione risulta coerente con il contesto storico e sociale odierno, nel quale è rilevante la gestione del rischio sanitario correlata a condotte colpose, a differenza di quello del legislatore del 1930 che vedeva lo spargimento di germi come prioritaria modalità di realizzazione dolosa. La scelta d’introdurre l’incriminazione dell’epidemia, non prevista dai codici preunitari né dal codice Zanardelli, venne infatti giustificata «[…] in rapporto alla enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi; capaci di cagionare una epidemia e di diffonderli […]»; non potendosi quindi desumere con certezza la volontà di escludere dall’àmbito della tipicità condotte realizzate in forma omissiva.
D’altra parte, l’osservazione secondo cui un’interpretazione ampia della disposizione lederebbe la sua capacità di selezione, assicurata dalla descrizione di uno specifico percorso causale, non sembra cogliere nel segno. Il riferimento alla «diffusione di germi patogeni» manterrebbe infatti una funzione selettiva dell’evento accentuandone il disvalore sotto il profilo della peculiare prospettiva di tutela: a essere vincolata non sarebbe la condotta, la quale ricomprenderebbe qualsiasi modalità di trasmissione della malattia, bensì il mezzo attraverso il quale si verifica l’evento; ciò rende applicabile l’art. 40 comma 2 c.p., ritenuto compatibile con i c.d. reati a mezzo vincolato.
A sostegno di tale ricostruzione, sta anche il rilievo che il legislatore costruisce le fattispecie incriminatrici come reati di evento a forma libera allorché intende apprestare una tutela particolarmente intensa al bene giuridico protetto, perché sanziona tutte le possibili modalità di aggressione; essendo tutelate la salute pubblica e l’incolumità collettiva è pertanto ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto descrivere l’epidemia come reato causalmente orientato.
In termini più generali, peraltro, si segnala che alcune pronunce della Suprema Corte confutano una delle premesse della tesi che esclude la realizzazione del reato di epidemia colposa in forma omissiva, affermando piuttosto che non è pacifica l’incompatibilità tra reati a forma vincolata e condotta omissiva (Sez. II, 3 ottobre 2023, n. 46209, in C.E.D. Cass., n. 285442; Sez. II, 18 aprile 2023, n. 24487, ivi, n. 284856; Sez. VI, 5 marzo 2019, n. 13411, ivi, n. 275463).
Il quesito
In definitiva, le Sezioni Unite sono chiamate a chiarire «Se il reato di cui agli artt. 438, comma 1 e 452, comma 1, n. 2 c.p. possa essere realizzato anche in forma omissiva».
L’udienza è fissata per il 10 aprile 2025 e il relatore designato è il Consigliere Andreazza.